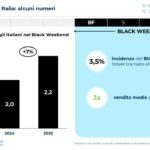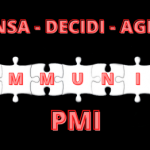Gli italiani vogliono vivere in quartieri con più negozi di prossimità, luoghi non solo di acquisto e offerta di servizi, ma che costituiscono, insieme agli spazi verdi, il principale elemento che contribuisce alla qualità della vita urbana; ma rappresentano anche veri e propri attivatori di socialità (per il 64% degli italiani), garanzia di cura e pulizia degli spazi pubblici (62%), presidi di sicurezza (60%). Il desiderio di avere più negozi sotto casa, per 2 italiani su 3, deriva dall’esigenza di avere più opportunità di scelta e ridurre gli spostamenti. Ma la presenza di attività commerciali incide anche sul mercato immobiliare: il valore di un’abitazione situata in un quartiere colpito dalla desertificazione commerciale scende del 16% con un differenziale complessivo che può arrivare al 39% rispetto a un immobile situato in un quartiere ricco di negozi. In ogni caso, negli ultimi 10 anni, gli italiani hanno percepito sempre più chiaramente le chiusure di attività economiche di quartiere, in particolare negozi di articoli sportivi, librerie, giocattoli (55%), abbigliamento, profumerie, gioiellerie (49%), arredamento e ferramenta (46%), alimentari (45%). Un fenomeno che, per la stragrande maggioranza degli italiani, genera un senso di tristezza e contribuisce al calo della qualità della vita.
Questi i principali risultati dell’indagine sulla desertificazione commerciale nelle città, realizzata da Confcommercio in collaborazione con SWG, presentata in occasione dell’iniziativa nazionale della Confederazione “inCittà – Spazi che cambiano, economie urbane che crescono” in corso di svolgimento a Bologna.
Il commercio di prossimità: presidio sociale ed economico delle città
Secondo gli italiani, i negozi di prossimità rappresentano il principale elemento che contribuisce alla qualità della vita urbana: al primo posto bar e ristoranti (78%), seguiti dagli spazi verdi (66%) e dai negozi (65%); trasporti, sicurezza e pulizia degli spazi pubblici sono, invece, gli elementi più critici. Le attività di quartiere sono riconosciute come presidi di comunità: per il 64% favoriscono la socialità, per il 62% migliorano la cura e la pulizia degli spazi pubblici, per il 60% aumentano la sicurezza e per il 57% tutelano le persone più fragili. Anche i dehors — pur con qualche criticità legata alla mobilità — sono apprezzati dagli italiani perché favoriscono la convivialità (84%) e rendono più belli gli spazi urbani (69%). In ogni caso, la presenza di negozi incide anche sul valore immobiliare delle aree urbane: un appartamento in una zona ricca di negozi vale mediamente il 23% in più rispetto a un immobile situato in un’area mediamente servita. Al contrario, nei quartieri colpiti dalla desertificazione commerciale il valore degli immobili scende del 16% con un differenziale complessivo che arriva al 39%.
Il desiderio di prossimità: 2 italiani su 3 vogliono più negozi sotto casa
Nonostante la crescita dell’e-commerce, il 67% degli italiani dichiara di volere più negozi di vicinato nel proprio quartiere per minimizzare gli spostamenti e il 68% vorrebbe un mix di negozi piccoli e medi per avere maggiori possibilità di scelta. Percentuali che raggiungono punte del 75% al Sud e nelle città medio-piccole. Il commercio locale, quindi, non è percepito come residuo del passato, ma come infrastruttura sociale che ancora oggi garantisce accessibilità, identità e vitalità urbana. E, a proposito di accessibilità, i trasporti pubblici emergono come l’elemento valutato più criticamente dagli italiani, poiché incidono sulla possibilità di fruire appieno degli spazi urbani e, in particolare, dei centri storici. Nei comuni con oltre 50.000 abitanti, il 58% degli intervistati afferma che migliorare i trasporti pubblici favorirebbe una maggiore frequentazione dei negozi e dei pubblici esercizi del centro. Seguono, le richieste di più parcheggi (43%) e di un ampliamento delle aree pedonali anche sacrificando gli spazi di sosta (42%), segno di una domanda pubblica articolata e di un equilibrio non semplice tra esigenze di accessibilità e desiderio di vivibilità.
La desertificazione commerciale e il suo impatto sulla vivibilità
La chiusura dei negozi continua a essere uno dei fenomeni più temuti e percepiti: l’80% degli italiani prova un senso di tristezza nel vedere saracinesche abbassate, il 73% collega la chiusura dei negozi al calo della qualità della vita. Rispetto a dieci anni fa le attività scomparse che gli italiani hanno notato maggiormente sono i negozi di libri, giornali, articoli sportivi e giocattoli (55%), le attività non alimentari – come abbigliamento, profumerie, fiorai, gioiellerie, ottici – (49%), ferramenta e negozi di arredamento e tessuti (46%), alimentari (45%), ambulanti (39%). Il fenomeno è più avvertito nel Nord-Est e nel Centro e nelle grandi città. Solo due categorie appaiono in controtendenza: farmacie e pubblici esercizi sono le uniche attività percepite in leggera crescita.
I luoghi di acquisto abituale
Le piccole attività sono le preferite per molte categorie, i supermercati dominano per gli alimentari a lunga conservazione, i mercati mantengono quota importante per il fresco e l’abbigliamento. Analizzando gli acquisti fisici (non online), i piccoli esercizi (negozi di quartiere, centro storico, ecc.) stravincono per bar/pub (88%), farmacie (87%), tabacchi e quotidiani (85%). Supermercati e grandi superfici (centri commerciali, ipermercati, outlet) sono preferiti, però, per l’acquisto di i prodotti alimentari a lunga conservazione (64%), articoli sportivi (58%), elettronica e telefonia (56%). Quote interessanti per i prodotti acquistati nelle attività di commercio ambulante, in particolare gli alimentari freschi (11%) e l’abbigliamento e calzature (10%).
L’impatto del turismo sul tessuto commerciale e gli affitti brevi sono percepiti come problematici dai residenti
Specialmente nelle città dove la pressione turistica è medio-alta, gli intervistati lamentano un aumento sbilanciato di attività dedicate al cibo (49%) e una crescita dei negozi per turisti con prodotti di bassa qualità (23%). Questo fenomeno, avvertito con più forza nelle grandi città, porta alla sostituzione dei negozi tradizionali con quelli dedicati ai turisti (17%), contribuendo a una perdita di servizi e di autenticità dell’offerta.
Gli affitti brevi sono visti come una causa rilevante della crisi abitativa nei centri urbani. Il 50% degli intervistati li associa direttamente all’aumento dei prezzi degli affitti per i residenti, mentre il 42% lamenta una conseguente diminuzione della disponibilità di alloggi (percentuali che salgono nelle grandi città). A fronte di un 24% che ne riconosce un beneficio nel “recupero di alloggi inutilizzati”, prevale nettamente una percezione negativa (46%).
Nota metodologica
L’indagine quantitativa è stata condotta mediante interviste online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview) su un campione composto da 1202 cittadini italiani tra i 18 e 80 anni rappresentativi della popolazione per genere, età, area geografica e scolarità. Le interviste sono state somministrate dal 17 al 24 ottobre 2025.